
Referendum, Benedetta Tobagi: "Un voto contro i depistaggi, per la verità"

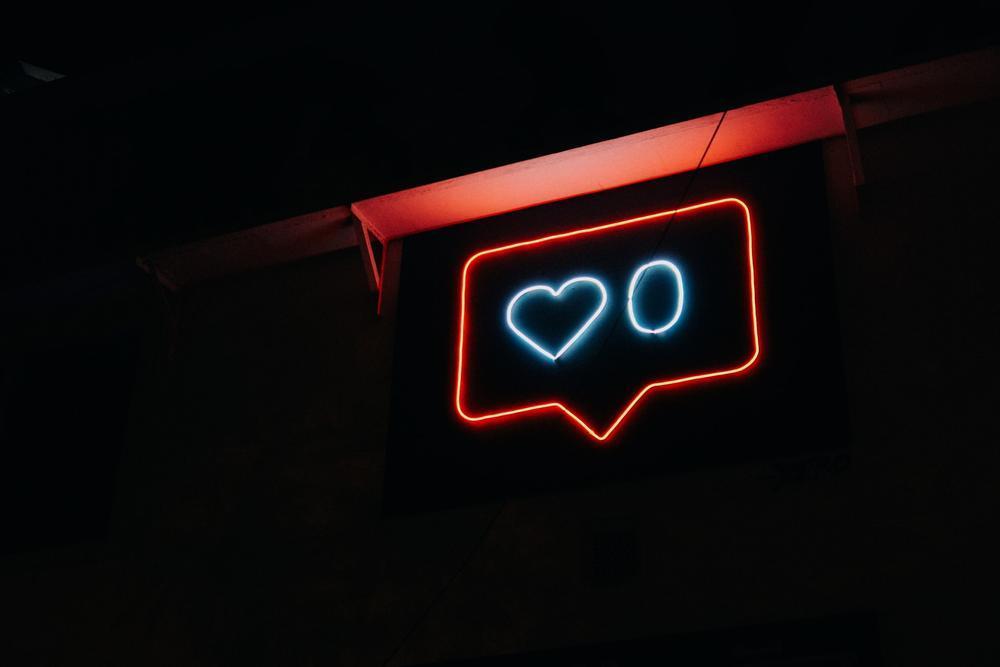

28 gennaio 2020
È quasi prassi, ormai: ogni volta che l’odio espresso online torna ai (dis)onori della cronaca, arriva una proposta di regolamentazione che mette in discussione l’anonimato in Rete. Una sorta di riflesso pavloviano. È successo anche lo scorso ottobre, quando un rapporto dell’Osservatorio antisemitismo ha svelato l’incredibile mole di attacchi, politici e religiosi, indirizzati a Liliana Segre, 89 anni, superstite dell’Olocausto e senatrice a vita. Una media di 200 messaggi al giorno. "Ora norme contro l’odio sui social e nel dibattito pubblico", ha subito dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sull’attenti si è fatto trovare il renziano Luigi Marattin che qualche giorno dopo ha scritto su Twitter di essere al lavoro su "una legge che obblighi chiunque apra un profilo social a farlo con un valido documento d’identità". La proposta ha collezionato consensi bipartisan, ma è stata duramente criticata da ricercatori, attivisti e giornalisti che, in un editoriale su Il Messaggero, l’economista Francesco Grillo ha definito "i talebani di Internet".
Lo confesso: dei "talebani" faccio parte anch’io. Non mi addentro in analisi tecniche e giuridiche sull’inattuabilità della schedatura di massa voluta da Marattin, che non mi competono, mi fermo prima. Il progetto del deputato di Italia viva, come molti fac-simile che l’hanno preceduto, è privo di fondamento perché si basa su due presupposti errati. Il primo è la presunzione che gli odiatori social siano sempre senza nome e cognome. Un falso mito. Come scrive l’antropologo Francesco Remotti su lavialibera, l’odio svolge una funzione antropo-poietica: viene usato per definire sé, nonché gli altri; e chi odia, anche in Rete, spesso mette con orgoglio la faccia. È il caso di Sebastiano Sartori, ex esponente di Forza Nuova, o di Marco Gervasoni, docente di storia contemporanea: entrambi autori di insulti diretti alla senatrice Segre.
Il secondo assunto è legato all’utilizzo improprio del termine anonimato quando si parla dell’impiego online di pseudonimi o nomi falsi. Sarebbe più corretto chiamarlo pseudo-anonimato ed è utile a chi, per esempio, soffre di patologie croniche e cerca supporto nei forum. Ma non rende irrintracciabile la nostra identità. Ognuno di noi si collega alla Rete, da computer o da smartphone, usando un determinato IP, cioè un indirizzo numerico che identifica univocamente il dispositivo connesso. Nel caso dei social, su richiesta dell’autorità giudiziaria, la polizia postale riesce facilmente a ottenerlo. Certo, esistono strumenti che permettono di mascherare l’IP, ma sono in pochi a sfruttarli e tra loro vanno menzionati i dissidenti politici che rischiano la vita in regimi autoritari.
Bandire e demonizzare queste tecniche così come lo pseudo-anonimato significherebbe danneggiare non tanto gli odiatori, ma soprattutto i più vulnerabili. Vale la pena? David Kaye, relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione, già nel 2015 si era espresso chiaramente in merito: "Leggi, pratiche e politiche che bandiscono o minano l’anonimato danneggiano significativamente, e in maniera sproporzionata, i diritti al cuore del mio mandato". Un talebano, anche lui.
Da lavialibera n° 1 gennaio/febbraio 2020
La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti
Riformata. Così il governo vorrebbe la magistratura, ma l'obiettivo è solo limitarne il potere
La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti