
Milano-Cortina. Ecco come verranno spesi i 450 milioni di euro delle paralimpiadi



24 luglio 2025
Per oltre vent’anni, la sostenibilità ambientale è stata il filo conduttore della mia vita professionale, il prisma attraverso cui ho osservato e interpretato le trasformazioni della nostra società. Ho visto crescere, evolversi e talvolta distorcersi il dibattito intorno al cambiamento climatico, all’economia circolare, alle politiche verdi. Dalle aule universitarie e dai convegni specialistici, questi temi sono arrivati fino ai tavoli dei governi, ai media, perfino nelle pubblicità. Eppure, a dispetto della loro onnipresenza, il cambiamento reale appare ancora timido, frammentario, fragile. È come se il linguaggio dell’urgenza ambientale si fosse svuotato di significato, trasformato in una narrazione di facciata. Perché accade questo? Perché, nonostante le informazioni, le leggi, i summit e le tecnologie, fatichiamo ancora a cambiare davvero?
Crisi climatica: piantare gli alberi non basta
Negli anni, mi sono convinto che la risposta risieda in un difetto di prospettiva. Abbiamo affrontato la crisi ecologica come un problema tecnico, da risolvere con strumenti giuridici, incentivi economici, target numerici. Ma la sostenibilità non è solo una questione di regolamenti e innovazione. È prima di tutto una questione culturale, emotiva, sensoriale. Un tema che tocca il nostro modo di abitare il mondo, di percepirlo, di entrare in relazione con esso. Serve un cambio di paradigma che vada oltre l’efficienza energetica e la decarbonizzazione. Serve una nuova coscienza ecologica, capace di restituire valore alla dimensione percettiva della natura. Serve, soprattutto, una riscoperta dell’ascolto.
Con la pandemia da Covid-19, in un vuoto acustico improvviso, abbiamo percepito per la prima volta, dopo tanto tempo, il suono dell’ambiente
Viviamo in una società iper-visiva, ma sempre più sorda. Il paesaggio sonoro che ci circonda – un tempo ricco, variegato, vivo – è stato lentamente colonizzato da un rumore di fondo costante, fatto di traffico, motori, notifiche, pubblicità, musica di sottofondo impersonale. È un suono che non racconta nulla, che non nutre, che ci isola. È il segno acustico della nostra disconnessione dalla Terra. La pandemia da Covid-19 ha rappresentato, per molti versi, uno spartiacque. Ricordo con vividezza i primi giorni del lockdown: le strade deserte, le città immobili, l’aria che sembrava più leggera, più respirabile. Ma soprattutto, ricordo il silenzio. Un silenzio nuovo, straniante eppure pieno. In quel vuoto acustico improvviso, abbiamo percepito per la prima volta, dopo tanto tempo, il suono dell’ambiente. I canti degli uccelli, lo scricchiolio dei rami, persino l’eco dei nostri passi: tutto sembrava amplificato, più nitido. Era come se il mondo ci stesse parlando di nuovo.
Eco-distopia: il racconto della catastrofe climatica nel romanzo italiano
Quel momento, seppur nella sua drammaticità, ha rappresentato per me una rivelazione. Un invito a rallentare, a riconnettersi, a tornare ad ascoltare. Eppure, è bastato poco per tornare alle abitudini precedenti. Il traffico ha ripreso a scorrere, le città a pulsare, il rumore a coprire tutto. Abbiamo perso quell’occasione preziosa per rieducare l’orecchio, per rifondare la nostra relazione con il paesaggio acustico.
Le metropoli moderne, come New York o Mumbai, registrano livelli sonori medi attorno ai 90 decibel: l’equivalente di un grido continuo
Il rumore che ci circonda non è solo fastidioso. È anche dannoso. Agisce in profondità, consuma la nostra attenzione, disgrega la nostra capacità di empatia, ci allontana dal presente. Le metropoli moderne, come New York o Mumbai, registrano livelli sonori medi attorno ai 90 decibel: l’equivalente di un grido continuo. Sarebbe impensabile vivere accanto a una persona che urla tutto il giorno. Eppure, accettiamo questo bombardamento acustico come se fosse la normalità. Perché di fatto abbiamo deciso di non ascoltare. E nel farlo, abbiamo perso qualcosa di essenziale.
Abbiamo perso la memoria sonora dei luoghi, quel patrimonio immateriale fatto di suoni naturali, di voci del territorio, di tracce acustiche che ci ancorano all’identità e alla comunità. Quando un paesaggio sonoro viene cancellato o alterato, perdiamo un pezzo di cultura, di storia, di connessione profonda con l’ambiente. In questa crisi percettiva, non stiamo solo smarrendo il senso dell’udito: stiamo smarrendo il senso di appartenenza.
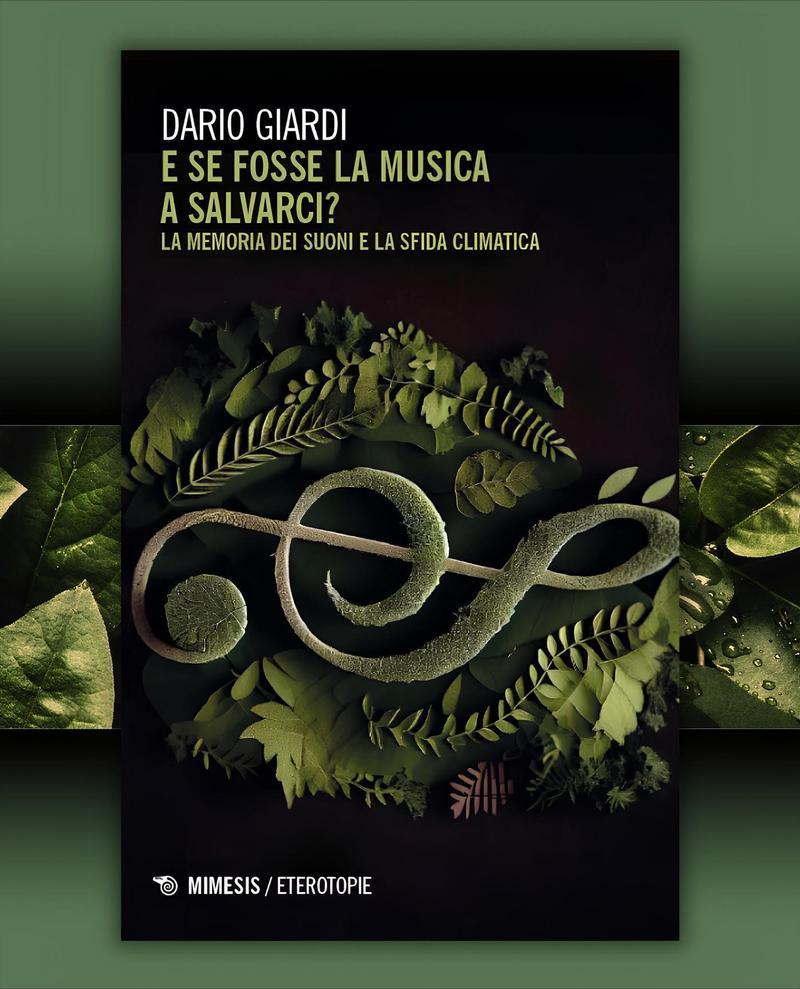
Nel mio saggio uscito di recente per Mimesis edizioni, dal titolo emblematico E se fosse la musica a salvarci? – La memoria dei suoni e la sfida climatica introduco un concetto a cui tengo particolarmente: quello di memoryscape. Se il soundscape è il paesaggio sonoro in cui siamo immersi ogni giorno, il memoryscape è il paesaggio sonoro che ci abita interiormente. È fatto di echi dell’infanzia, di suoni che hanno segnato momenti, affetti, luoghi. È un paesaggio invisibile ma vivido, composto dalle impronte acustiche che ci accompagnano, anche quando non ne siamo più consapevoli.
Questo concetto non è solo teorico. È diventato per me anche un progetto artistico e musicale, un’estensione sonora del mio saggio, che ho voluto realizzare sotto il mio alias artistico musicale, Giadar. Ho voluto tradurre la riflessione sulla crisi ecologica e sensoriale in un’esperienza d’ascolto, un'opera ambientale che potesse toccare la dimensione emotiva prima ancora che intellettuale.
Nel progetto Memoryscape, ho raccolto suoni del mio passato, quelli che custodivo nella memoria e che rischiavano di andare perduti. Ho ripercorso i sentieri dell’infanzia, armato di microfono e pazienza, per registrare la cascata e il fiume vicino a casa, il ronzio delle api sui fiori in primavera, le onde del mare durante le passeggiate con i miei nonni, e il fruscio del muschio che raccoglievamo al parco per il presepe, rituale semplice ma carico di significato. Questi suoni sono diventati tessere di un mosaico sonoro costruito attorno al mio vecchio pianoforte, suonato in presa diretta e trattato solo con delay e un filtro analogico per evocare l’effetto caldo e imperfetto dei dischi di vinile.
Ascoltare è un atto trasformativo. Non è un gesto passivo, ma una forma di partecipazione. È la chiave per una sostenibilità che non sia solo tecnica, ma anche esistenziale e sensibile.
I Guardiani della foresta amazzonica sono dispositivi acustici che registrano i suoni della giungla e identificano il ronzio delle motoseghe grazie a un’intelligenza artificiale. In tempo reale, inviano allarmi alle autorità e alle comunità indigene. Qui, l’ascolto diventa difesa
Pensiamo all’agricoltura biosonora, una pratica che affascina e incuriosisce sempre più studiosi e imprenditori agricoli: attraverso specifiche frequenze e vibrazioni, la musica stimola la crescita delle piante, migliora la loro salute, aumenta la qualità dei raccolti e le performance dei vini. Non è una fantasia new age, ma una disciplina in espansione che affonda le radici negli studi pionieristici del botanico T.C. Singh negli anni ’60. Oggi, vigneti, serre e orti sperimentano l’uso di suoni armonici per dialogare con il mondo vegetale, ricordandoci che ogni essere vivente risponde a un ritmo, a una frequenza, a una vibrazione. Oppure pensiamo al lavoro dei “Guardiani” della foresta amazzonica: dispositivi acustici che, sospesi sugli alberi, registrano i suoni della giungla e identificano il ronzio delle motoseghe grazie a un’intelligenza artificiale. In tempo reale, inviano allarmi alle autorità e alle comunità indigene. Qui, l’ascolto diventa difesa, tecnologia che protegge la vita.
Il rumore può degenerare in violenza. Per tenerlo sotto controllo servono calma, ordine e silenzio
Anche il mondo dell’arte e della ricerca sta rispondendo a questa esigenza. Il Global Soundscapes Project, guidato dal professor Bryan Pijanowski, raccoglie e analizza paesaggi sonori da tutto il mondo per documentare la biodiversità acustica e monitorare i cambiamenti ambientali. Iniziative come questa ci ricordano che ogni luogo ha una voce, e che preservare i suoi suoni significa preservarne l’anima.
Alcuni studi recenti sull’archeoacustica lo confermano: molte strutture megalitiche europee e sudamericane risuonano attorno ai 110-120 Hz, frequenze che stimolano specifiche risposte cerebrali e fisiologiche
Credo profondamente che l’educazione all’ascolto debba diventare parte integrante del nostro impegno ecologico. Non si tratta solo di imparare a riconoscere i suoni del mondo naturale, ma di riattivare una forma di percezione profonda, una facoltà sensibile che abbiamo silenziato in favore della visione, della velocità, del controllo. Dobbiamo imparare a sentire di nuovo. Sentire nel senso più pieno del termine: essere attraversati dai suoni, lasciarsi toccare, modificare, riorientare da essi.
In questo, le culture antiche avevano molto da insegnarci. Gli acustimantici della scuola pitagorica, ad esempio, attribuivano al suono una funzione divinatoria e conoscitiva. Credevano che ogni vibrazione, ogni frequenza, fosse in risonanza con l’ordine cosmico. Il suono, per loro, non era intrattenimento, ma rivelazione. Era lo strumento attraverso cui armonizzare l’anima con il tutto, decifrare l’invisibile, curare gli squilibri interiori.
Rave party, il "dionisiaco" tra analisi chimica e manganello
È proprio da questa visione che nasce l’idea di musica delle sfere, quella melodia eterna e impercettibile che tiene insieme il cosmo, i pianeti, il tempo e la vita. L’orecchio, in questa prospettiva, non è un senso inferiore, ma una soglia sacra: il punto in cui il microcosmo umano incontra il macrocosmo naturale. Anche le grandi civiltà preclassiche e arcaiche avevano sviluppato una profonda consapevolezza bioacustica. Molti templi egizi, greci, maya, celtici non erano costruiti solo in base a criteri astronomici o geometrici, ma anche in relazione alla risposta sonora del paesaggio. Venivano scelti luoghi e materiali in grado di esaltare particolari frequenze, di generare eco naturali, di canalizzare vibrazioni benefiche.
Quegli spazi erano pensati per essere esperienze acustiche immersive, capaci di mettere il visitatore in contatto con il divino, con la Terra, con sé stesso. Alcuni studi recenti sull’archeoacustica lo confermano: molte strutture megalitiche europee e sudamericane risuonano attorno ai 110-120 Hz, frequenze che stimolano specifiche risposte cerebrali e fisiologiche. La sacralità del suono naturale, in queste culture, era una forma di conoscenza profonda, un sapere incarnato che attraversava medicina, spiritualità, agricoltura, architettura. Un sapere oggi quasi dimenticato.
Credo che la musica, l’ascolto e la memoria sonora siano strumenti essenziali per il futuro dell’umanità. Un futuro che non può essere solo sostenibile. Deve essere anche sensibile
Per questo, oggi più che mai, dobbiamo riscoprire quella sacralità perduta. Dobbiamo tornare a considerare il suono non come un semplice fenomeno fisico, ma come un linguaggio dell’ecosistema, una grammatica invisibile che ci racconta la salute di un luogo, l’equilibrio tra le specie, il respiro della Terra. Ogni fruscio, ogni richiamo, ogni risonanza ci parla di equilibri invisibili, di connessioni profonde, di armonie da custodire. Rieducarci all’ascolto significa rieducarci al rispetto. Significa imparare a stare nel mondo con attenzione, con meraviglia, con responsabilità. Significa anche accogliere il silenzio come spazio vivo, e non come vuoto da riempire.
Tutti i nostri articoli su ecologia e movimenti
In un tempo dominato dal rumore, dal frastuono mediatico, dalla sovrapproduzione sensoriale, ascoltare diventa un atto sovversivo. Un gesto rivoluzionario. Un passo fondamentale per una ecologia del sentire. Solo tornando a sentire il mondo nella sua sottile musicalità potremo davvero proteggerlo. Perché si protegge solo ciò che si ama. E si ama solo ciò che si conosce intimamente. E nulla, come il suono, ci permette di conoscere davvero. Per questo, credo che la musica, l’ascolto e la memoria sonora siano strumenti essenziali per il futuro dell’umanità. Un futuro che non può essere solo sostenibile. Deve essere anche sensibile. Forse non saranno le tecnologie, né le leggi, né i grandi summit a salvarci. Forse a salvarci sarà una nuova capacità di ascoltare, un modo diverso di essere presenti. Forse a salvarci sarà la musica, se tornerà a essere un ponte tra il cuore e il paesaggio, tra la memoria e il futuro.
Crediamo in un giornalismo di servizio di cittadine e cittadini, in notizie che non scadono il giorno dopo. Aiutaci a offrire un'informazione di qualità, sostieni lavialibera
La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti
La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti