
Milano-Cortina. Ecco come verranno spesi i 450 milioni di euro delle paralimpiadi




2 febbraio 2025
“Se questo libro ha qualche ambizione, una è senz’altro far capire al lettore che un percorso riabilitativo in una comunità di pari rimane, a oggi, lo strumento di elezione non solo per emanciparsi dalla dipendenza ma anche per dare alla propria vita una svolta positiva, questo banalmente perché curare il sintomo, la dipendenza, vuol dire risolvere la sofferenza alla vita, della vita, che porta ad avere una dipendenza come auto cura alla stessa. Per loro la vita è malattia”.
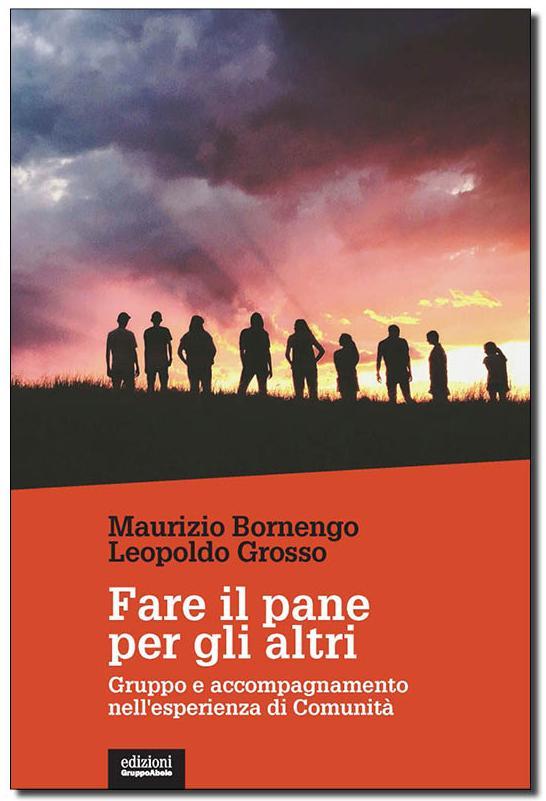
“Loro” sono donne, uomini, giovani e giovanissimi, ma anche adulti, persone con alle spalle una dipendenza cronica. Li accomuna l’abuso di sostanze e i comportamenti che ne derivano, a tal punto da aver messo in crisi la quotidianità, le relazioni, il senso, la vita. Delle persone dipendenti e dei loro percorsi nelle comunità terapeutiche raccontano Maurizio Bornengo – imprenditore dell’accoglienza, operatore, esperto per esperienza, scomparso nel 2022 – e Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta, specialista di dipendenze e trattamento, formatore e consulente, presidente onorario della Fondazione Gruppo Abele. Ne parlano nel saggio Fare il pane per gli altri. Gruppo e accompagnamento nell’esperienza di Comunità, in libreria da novembre 2024 per le Edizioni Gruppo Abele. Un libro nato dall’esigenza di mettere a fuoco attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze reciproche, l’evoluzione del ruolo e della funzione della comunità come strumento terapeutico in questi ultimi 40 anni.
24 ore nel centro crisi contro le nuove dipendenze da crack e nuove droghe
“La domanda di trattamento – scrive Leopolodo Grosso – perde [oggi] ogni caratteristica di omogeneità: non c’è più un’unica tipologia delle persone ospitate, per cui gli obiettivi e gli strumenti a disposizione non sono adeguati per tutti. La ‘scena della droga’ si è molto trasformata. Così come la società e il sistema di welfare. Non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. I consumatori di eroina invecchiano e accumulano le problematiche precocizzate dell’età più avanzata; il carcere, sovraffollato di persone dipendenti, preme una collocazione detentiva in comunità; l’utenza inviata dai SerD (servizi per le dipendenze, ndr) associa alla dipendenza sintomatologie d’ordine psichiatrico; la domanda di cura dei giovani policonsumatori, degli utilizzatori di cocaina e crack in particolare, si differenzia ampiamente per motivazioni, problemi retrostanti, obiettivi da conseguire. Le esigenze, anche istituzionali, sono di programmi terapeutici individualizzati, che richiedono più attenzioni e impegno, ma al contempo i budget per le comunità vengono sottofinanziati e le rette regionali sono ferme da due decenni. Il lavoro in struttura diventa più stressante, le collaborazioni son i SerD, diminuiti nell’organico, più complicate”.
Crack, la droga ninja: "finché non ti ammazza non la vedi"
Una comunità deve certamente puntare a emancipare le persone dalle sostanze, ma più di tutto deve renderli capaci di convivere con la loro sofferenza in modo non distruttivo
Concorde nell’analisi, Maurizio Bornengo, in una sorta di testamento professionale, denuncia a sua volta come oggi le comunità rischino di diventare i “contenitori” di un numero imprecisato e complesso di fenomeni che altrimenti comporterebbero ricadute, costi e rischi per la società. Contenitori uguali per tutti, scarsamente conciliabili con un intervento terapeutico mirato e funzionale al benessere di ciascuno. Al tempo stresso rilancia sulla necessità che la comunità terapeutica per persone dipendenti si riappropri delle sue funzioni originarie, l’accompagnamento e l’educazione.
Stare in prossimità della sofferenza, accostarsi a un percorso e sostenerlo è il nodo originario attorno al quale far convergere ogni sforzo. Questo è il lavoro della comunità e dei suoi operatori. Educare nel senso di anteporre alla sofferenza una motivazione per liberarsi dalla dipendenza. Non al cambiamento, concetto spesso usato con troppa semplicità per il percorso di comunità, ma all’evoluzione del proprio progetto di vita. Perché “l’uomo non cambia, cresce”. Una comunità deve certamente puntare a emancipare le persone dalle sostanze, ma più di tutto deve renderli capaci di convivere con la loro sofferenza in modo non distruttivo. E poi ricondurli, per piccoli passi, verso a una vita gratificante. “Ciò che cura è semplicemente la convivenza con la sofferenza degli altri che permette di reificare la propria con la mediazione degli operatori all’interno di uno spazio di protezione. Questo è la comunità. Null’altro”.
Politiche antidroga: luci sul fentanyl, ombre sul resto
La comunità come luogo di condivisone e convivenza. Come spazio di vita. Con le necessità più comuni, da quella di un ambiente piacevole e accogliente fino a quella di relazioni costruttive tra ospiti e operatori, tra gli stessi operatori e soprattutto tra i pari. La convivenza, spiega Bornengo, funziona perché si impara a specchiarsi nell’altro, nella stessa dipendenza. Nella sofferenza dell’altro si vede la propria. Nei comportamenti dei pari, nello svelamento delle maschere, si guadagna consapevolezza di sé. “Questo deve fare la comunità terapeutica: lasciare le persone in cura libere di riappropriarsi della loro innata capacità di empatia, empatia bloccata dalla loro dipendenza. Questo si può fare solo con la relazione con i pari”.
Al tempo stesso la comunità terapeutica deve essere prototipo di vita sociale gratificante, nel quale gli ospiti possano provare di nuovo a essere autentici. È il luogo in cui si pratica il servizio all’altro, si sperimenta il piacere di contribuire alla vita collettiva. Dove fare il pane per gli altri può essere una soddisfazione indicibile, può far apprezzare la gratuità dei gesti quotidiani non più esclusivamente rivolti a sé e alla propria dipendenza, ma condivisi con un gruppo. È proprio nel gruppo terapeutico che l’ospite “riesce a parlare per la prima volta del suo dolore, quando sente altri parlare del loro senza sollevare scandalo, perché ne sente parlare come una malattia dalla quale si guarisce, la malattia della libertà”. Per Bornengo “la comunità è il gruppo terapeutico e il gruppo terapeutico è la comunità. Non può esserci gruppo terapeutico così inteso senza una comunità”.
Gli operatori sono professionalmente consapevoli dei processi di crescita degli individui e dei gruppi, e sono disponibili a cedere il potere necessario per lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità dei beneficiari
Non solo gruppo. Il rafforzamento e l’efficacia del percorso scaturiscono anche dal piano soggettivo quando, ad esempio, gli ospiti fanno esperienza dell’empowerment, del protagonismo. Quando si scoprono capaci di fare delle cose, di portare avanti delle attività gratificanti per sé stessi e utili a tutti. Accompagnate dall’operatore nello stimolo costante della motivazione le persone che vivono in comunità ritrovano il senso di efficacia e smettono di girare intorno al pensiero unico e divorante della dipendenza.
“La sapienza degli operatori – spiega bene Leopoldo Grosso – impone loro un passo indietro nella gestione della comunità, per lasciare spazio al protagonismo delle persone che conducono il percorso, evitando di porsi come limite al dispiegamento delle potenzialità degli ospiti. Un passo indietro del protagonismo dello staff è indispensabile per favorire il proporsi delle persone accolte. Il compito degli operatori sta nello stimolare, supportare, contenere, mediare, monitorare. Stimolare comportamenti inerti o a traino, supportare da un punto di vista tecnico o emotivo, contenere gli eccessi, mediare i conflitti, monitorare l’andamento complessivo e il clima della comunità.
Idealmente, gli operatori dovrebbero agire più come ‘consulenti al bisogno’ dell’esercizio del protagonismo degli ‘utenti’ che si fanno carico nel condurre la struttura, ed essere sempre meno i gestori della stessa. L’empowerment di qualcuno è sempre a scapito della perdita di potere di qualcun altro. Il punto di forza, in questa situazione, è che gli operatori sono professionalmente consapevoli dei processi di crescita degli individui e dei gruppi, e sono disponibili a cedere il potere necessario per lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità dei beneficiari. Cedere potere è una scommessa educativa, ed è una decisione che va presa a ragion veduta, nella valutazione costante dei singoli e delle dinamiche di gruppo. Ma senza protagonismo nelle scelte da parte degli “ospiti”, non c’è esercizio di responsabilità. Se le persone in percorso rimangono utenti, esecutori passivi di scelte e decisioni altrui, il processo di crescita non solo è più lento, ma anche tarpato e più a rischio. Già la comunità si raffigura come una campana di vetro in cui il percorso è protetto dalle insidie permanenti del fuori. Bisogna evitare che all’interno di questa campana di vetro se ne crei un’altra, che può risultare ben più opprimente e asfissiante, nel limitare il protagonismo e il livello di sfide a cui le persone si vogliono mettere alla prova”.
Accompagnamento, servizio, gruppo, protagonismo. Sono le fondamenta del lavoro di accoglienza, da esse dipende l’evoluzione dei percorsi di comunità per le persone dipendenti che oggi, come decenni fa, intraprendono un percorso di cura in una struttura residenziale. Percorsi complessi, spesso interrotti o abbandonati, altre volte vissuti a più riprese. Una strada che si sceglie di percorrere – a volte in autonomia, a volte come alternativa alla detenzione – con le motivazioni più varie, ma sempre in vista di una crescita personale. Cioè con l’obiettivo di una migliore condizione di vita complessiva, che non si basa solo sul grado di autocontrollo che si raggiunge verso la dipendenza, ma che ha radici più profonde, radici che attingono a una nuova consapevolezza di sé e al bisogno di essere felici.
Come ha scritto Bornengo: “Perché qualcuno deve smettere di farsi? […] La risposta non può essere, non deve essere: ti salvi la vita e basta. La risposta deve comprendere in nuce la felicità”.
Crediamo in un giornalismo di servizio a cittadine e cittadini, in notizie che non scadono il giorno dopo. Aiutaci a offrire un'informazione di qualità, sostieni lavialibera
Diventare un lettore registrato de lavialibera.it non costa nulla e ha molti vantaggi. Avrai accesso a contenuti inediti dedicati e riceverai le nostre newsletter: ogni sabato la raccolta degli articoli della settimana e ogni prima domenica del mese un approfondimento speciale.
Registrati ora!Se sei già registrato clicca qui per accedere e leggere l'articolo