
Milano-Cortina. Ecco come verranno spesi i 450 milioni di euro delle paralimpiadi



23 dicembre 2022
Una delle affermazioni più ricorrenti nel dibattito sull’ecologia è l’inequivocabile "dovremmo fare quel che dice la scienza", dove con scienza si intende la variante cosiddetta "dura" – dall’inglese hard science –, "esatta", "naturale". Ecco allora che climatologi, biologi, geologi, etc., considerati come parti del tutto che è la comunità scientifica, per la porzione d’opinione pubblica più sensibile ai temi ecologici, assurgono al ruolo di guide, depositari di un sapere capace di dar conto del presente e di predire il prossimo, fosco futuro, indicando al contempo i possibili rimedi a un legislatore troppo spesso indolente. Prima arma nella panoplia degli scienziati sono, come sappiamo, i dati: un profluvio di numeri, grafici e tabelle che in drammatiche serie storiche tendenti a un rosso man mano più scuro fotografano la catastrofe in atto, individuando senz’appello le responsabilità del genere umano.
Meno determinante sembra essere l’apporto offerto alla questione dalle altre scienze cosiddette "molli" – soft sciences –, umane, sociali. Come se la faccenda ecologica non debba riguardare il pensiero o la postura etica, umana, psichica e sociale da adottare. La sacrosanta fede che abbiamo nelle scienze dure rischia così di oscurare l’apporto di quelle umanistiche.
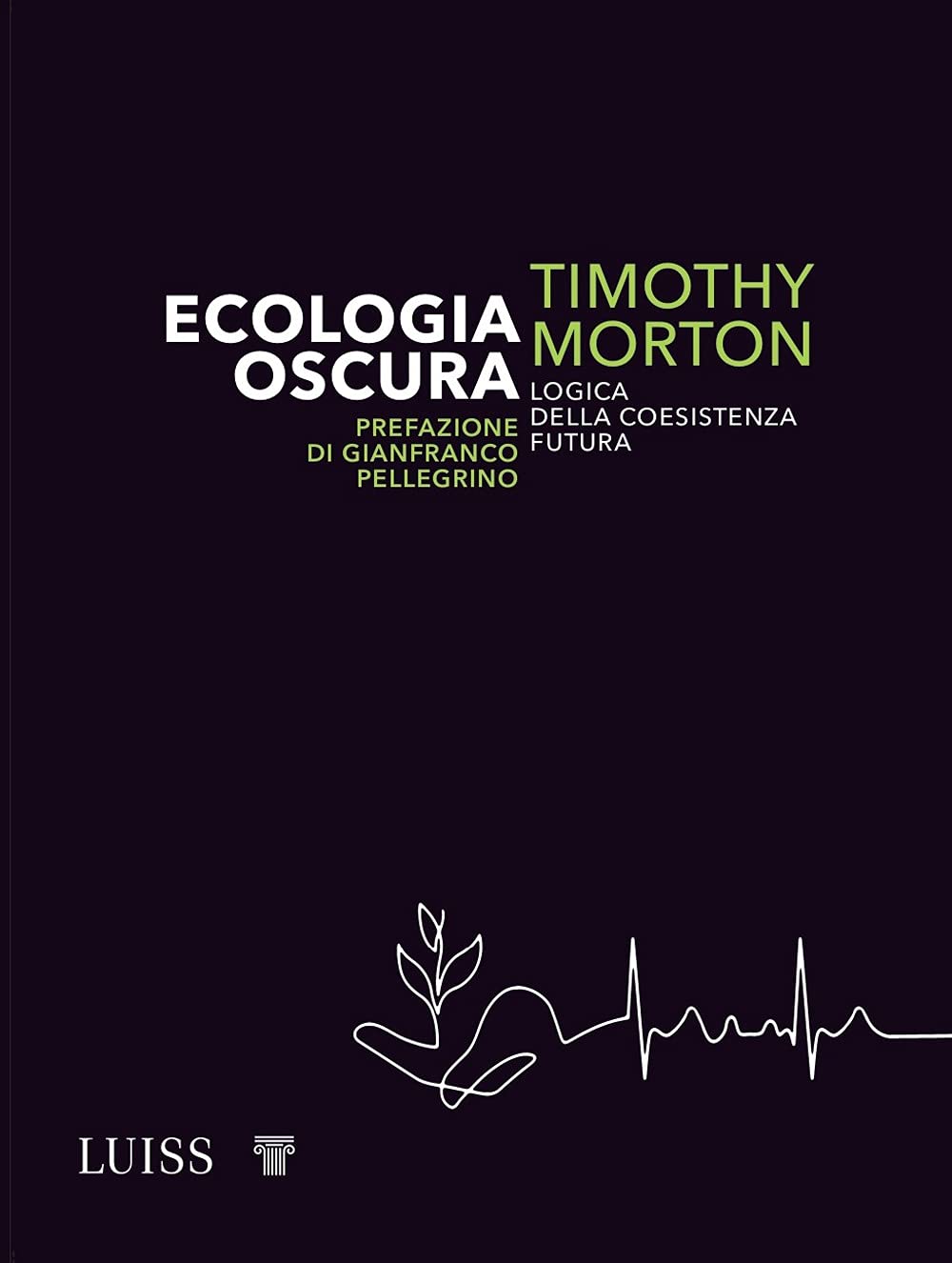
Su questa parziale assenza, e sulla constatazione che finora l’evidenza dei dati non ha portato a cambiamenti nell’agire collettivo, come dimostrano i dati stessi, s’innesta una delle voci più originali nel dibattito ecologico attuale. Si tratta del filosofo Timothy Morton (1968), docente a Houston, dal cui lavoro si traggono non già delle prescrizioni comportamentali rispetto alla crisi, bensì delle modalità di riflessione e rappresentazione dello smisurato problema che ci tocca vivere. Base di partenza di Morton è la corrente filosofica nota come Ontologia orientata agli oggetti (OOO). Una filosofia distante dall’antropocentrismo e che pone il genere umano e i suoi singoli esemplari sullo stesso piano ontologico – cioè relativo all’essere in quanto tale – di pietre, camosci, muschi, virus, nuvole, macchine etc., in uno scenario prossimo all’animismo in cui gli oggetti, tra loro sempre connessi, hanno capacità di azione, anche se non un’intenzionalità consapevole simile alla nostra. In breve, secondo la OOO una realtà esiste ed è fatta di oggetti che agiscono, ma non ha l’essere umano al centro né risulta accessibile per intero, ciò a cui si può accedere sono solo alcuni aspetti degli oggetti e alcune relazioni incomplete, perché limitate alla nostra limitata esperienza, che li tengono costantemente collegati.
Di pandemie, catastrofi e salvaguardia degli affetti

Da questo assunto della OOO Morton trae un presupposto: la natura, per come l’abbiamo sempre pensata da umani in quanto specie e singoli individui, non esiste, poiché da 12mila anni a questa parte – ovvero da quando in Mesopotamia abbiamo dato vita all’agrilogistica, progetto di produzione e allocazione delle risorse per il sostentamento e l’espansione della specie, impensabile senza patriarcato, specismo e stratificazione sociale in caste/classi (si veda Ecologia oscura. Logica della coesistenza futura, Luiss University Press 2021) – ci siamo impegnati a separarla da noi, relegandola al ruolo di risorsa da sfruttare o di santuario da difendere, riducendola a merce e regolandola tramite i dispositivi dell’economia o della giurisprudenza. Si pensi alla conta dei danni in euro dopo una catastrofe meteorologica e al dibattito sui diritti di soggetti naturali come fiumi, foreste, ghiacciai etc. Ma la natura, secondo Morton, non è riducibile all’uno né all’altro modello, e non possiamo più pensarla separata da noi. Piuttosto dovremmo superare il concetto stesso di natura e considerare l’ambito umano e il non-umano come aspetti che si compenetrano nell’insieme degli oggetti che popolano il mondo. La questione sta tutta qui: pensare la convivenza tra umano e non-umano rappresentando i due termini come omogenei, mai separati, e considerando l’apporto che la filosofia e l’arte possono offrire nell’impresa.
"Pensare in modo ecologico – dice Morton in Come un’ombra dal futuro (Aboca 2019) – può essere abbastanza diverso dalle nostre supposizioni. Non ha a che fare solo con le scienze dell’ecologia, […] ha a che fare con l’arte, la filosofia, la letteratura, la musica e la cultura […]. Ma ha anche a che fare con le fabbriche, i trasporti, l’architettura, l’economia. L’ecologia racchiude tutti i modi immaginabili in cui si può vivere insieme". Rifiutare il concetto di natura per dare pari dignità a umani e non-umani, e immaginare possibilità di convivenza, è il primo passo per pensare in modo ecologico. Un passo che ci aiuta nel comprendere le dinamiche esibite dagli oggetti e la loro interazione, come detto conoscibili solo in parte.
L'immaginario per reagire al collasso

Per chiarirci come gli oggetti agiscano e per dar conto di come la nostra specie si muova nella loro trama d’interazioni, nel libro seminale Iperoggetti (Nero 2018) Morton ne individua un tipo specifico: gli "iperoggetti", appunto, che caratterizzano la nostra epoca perché solo ora abbiamo cominciato ad accorgerci della loro esistenza. Si tratta di entità che vivono su scale spazio-temporali estesissime e hanno effetti commisurati a tale estensione. Nella pratica dell’ecologismo, ci mettono davanti a un fatto: l’azione in contrasto alla crisi non può rivolgersi ad ambiti circoscritti, ma deve considerare estensioni di scala difficili da immaginare, unità di misura indefinite e ambigue, la continua compenetrazione degli oggetti. Ovvero: nulla si risolve collocandoci nel "qui ed ora", piuttosto si deve allargare quanto più possibile l’orizzonte interpretativo e d’azione.
Ma quali sono, nello specifico, questi iperoggetti? Per esempio i buchi neri, che si sviluppano nel corso di miliardi di anni e influenzano con forze gravitazionali astri molto distanti, determinandone l’esistenza o la sparizione. Oppure il plutonio nelle scorie della lavorazione nucleare, che ha un’emivita – il periodo di dimezzamento chimico della massa di elementi radioattivi – di 24mila anni, ed emette radiazioni in intervalli di tempo lunghissimi, con tutto ciò che ne consegue per la società e non solo. Oppure, per venire a noi, il cambiamento climatico, fenomeno causato da micro-azioni di miliardi di persone diffuse sul globo, in un periodo di 12mila anni, capace di estendere i suoi effetti, una volta attivato, al di là di chi l’ha innescato.
Per una singola persona, dato il suo breve orizzonte biografico, porsi in relazione agli iperoggetti in simili scale spazio-temporali può tuttavia essere repulsivo, di sicuro straniante, o meglio strano. Ma familiarizzare con la stranezza è proprio ciò che per Morton bisogna fare per riconoscere la dinamica della crisi climatica e collocarci in essa in prospettiva futura. Perché tutto è strano: lo sono gli iperoggetti, che pur permeandoci si ritraggono alla nostra conoscenza apparendo letteralmente spettrali, e lo siamo noi.
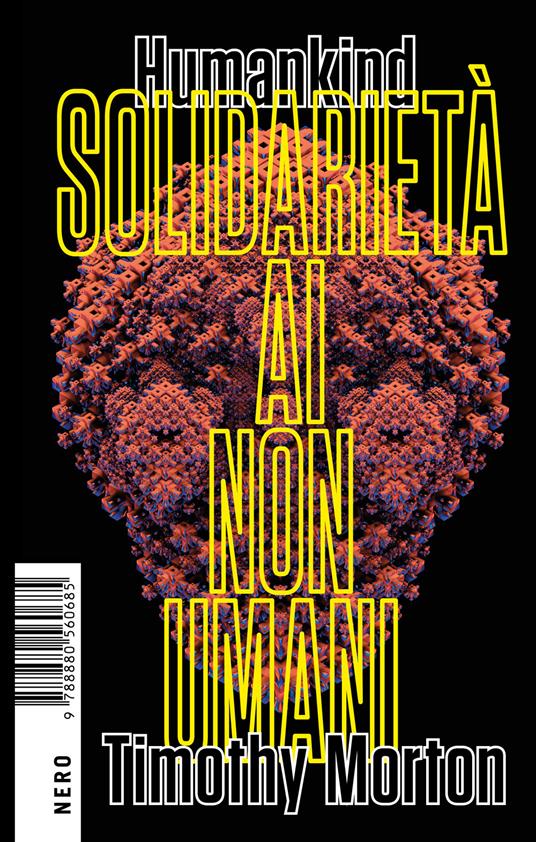
Iperoggetto è infatti anche il genere umano, ideale per descrivere un’altra caratteristica di queste entità iperestese: la subscedenza, ovvero l’essere minore della somma delle proprie parti. Nel nostro caso, il genere umano è subscedente perché non è qualcosa di più rispetto alla somma delle singole persone che lo compongono, ma qualcosa di meno, di diverso. Ciascuna persona è infatti letteralmente infestata da non-umani, popolata e attraversata di continuo da entità non riducibili all’umano. Su tutti, i batteri che albergano nei nostri visceri: chili di non-umani che ci infestano e ci fanno sopravvivere. Considerarci come ambienti infestati, contenitori di moltitudini viventi che confutano le leggi moderne della soggettività – dove finisco io e dove cominciano i miei batteri? –, è per Morton un passo fondamentale verso l’ecognosi, o "consapevolezza ecologica": il processo di riconoscimento che ci porta a vedere umano e non-umano come parte del cosiddetto "reale simbiotico", concetto che Morton usa in sostituzione di quello di realtà.
Tutto, secondo il filosofo, vive in solidarietà, in simbiosi, ed è stata proprio la scienza dura a dircelo: si pensi al lavoro pionieristico della biologa Lynn Margulis (1938-2011) e al suo sostegno alla teoria dell’endosimbiosi, per la quale le forme di vita complesse si sarebbero sviluppate in principio non grazie alla competizione – la sopravvivenza del più forte –, bensì grazie alla cooperazione, che avrebbe dato il via all’evoluzione quando alcune cellule semplici ne avrebbero inglobate altre perché diventassero mitocondri, i motori cellulari che generano l’energia. Proprio su stranezza, spettralità e subscedenza, e sul bisogno di accettarle per immaginare un futuro ecologico di convivenza solidale tra umani e non-umani, è incentrato Humankind. Solidarietà ai non umani, libro di recente pubblicato da Nero edizioni. Ragionando a braccio libero e in maniera del tutto irrituale sui temi fin qui esposti, ed evocando una pletora di riferimenti eterogenei tra cui Primo Levi, Jacques Derrida, Charles Baudelaire, Martin Heidegger, Giorgio de Chirico, Theodor W. Adorno, Björk e Christopher Nolan, Humankind cerca di rispondere a un’esigenza: adeguare il marxismo al pensiero ecologico e indicare alla sinistra un nuovo modo di pensare il mondo per superare lo specismo che permea il pensiero di Marx nella riduzione della natura a merce. Il libro, come dice il titolo, vuole porre le basi per immaginare l’integrazione tra umani e non-umani partendo dalla constatazione che la solidarietà è "lo stato basico della biosfera", ovvero "lo scambio ambientale standard negli strati superiori della crosta terrestre […], immediatamente disponibile proprio perché riposa sullo strato basilare del reale simbiotico".
A differenza di quanto sostengono molti approcci ecologici, in quello di Morton l’integrazione tra umani e non-umani rifiuta l’analogia tra comportamento ecologico e frustrazione dei piaceri. Al contrario, sostiene il godimento: il nostro e quello dei non-umani. Scrive Morton: "Se vogliamo immaginare una società ecologica a venire" dovremmo "fare i conti con il modo in cui organizziamo il piacere su vasta scala, la scala della nostra coesistenza. Una società ecologica che non mette al centro la valorizzazione e la diversificazione del piacere è ecologica solo per modo di dire. Sarà lo stesso concetto di utile a dover essere aggiornato". In altre parole, lo spazio sociale dovrà includere ora anche i non-umani e tenere in considerazione il loro godimento, non solo il nostro. Il vegetarianismo, per esempio, non deve consistere "semplicemente nell’opporsi alla crudeltà, nel ridurre il carico di sofferenza di altri animali", ma nel "sostenere o aumentare le modalità di piacere dei maiali o delle vacche o delle pecore".
Tuttavia, al di là di queste riflessioni di ampio raggio, poco o nulla Morton ci dice su come debba avvenire questa necessaria riorganizzazione dei piaceri, né suggerisce in tal senso concreti indirizzi d’intervento politico-sociale. Il suo resta un approccio all’apparenza ancorato solo al pensiero, cosa che giustamente invita i critici a dubitarne. Ma nonostante ciò il suo valore per la pratica resta, o almeno si spera, per quanto in modi che vanno ancora individuati.
La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti
La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti