
Milano-Cortina. Ecco come verranno spesi i 450 milioni di euro delle paralimpiadi

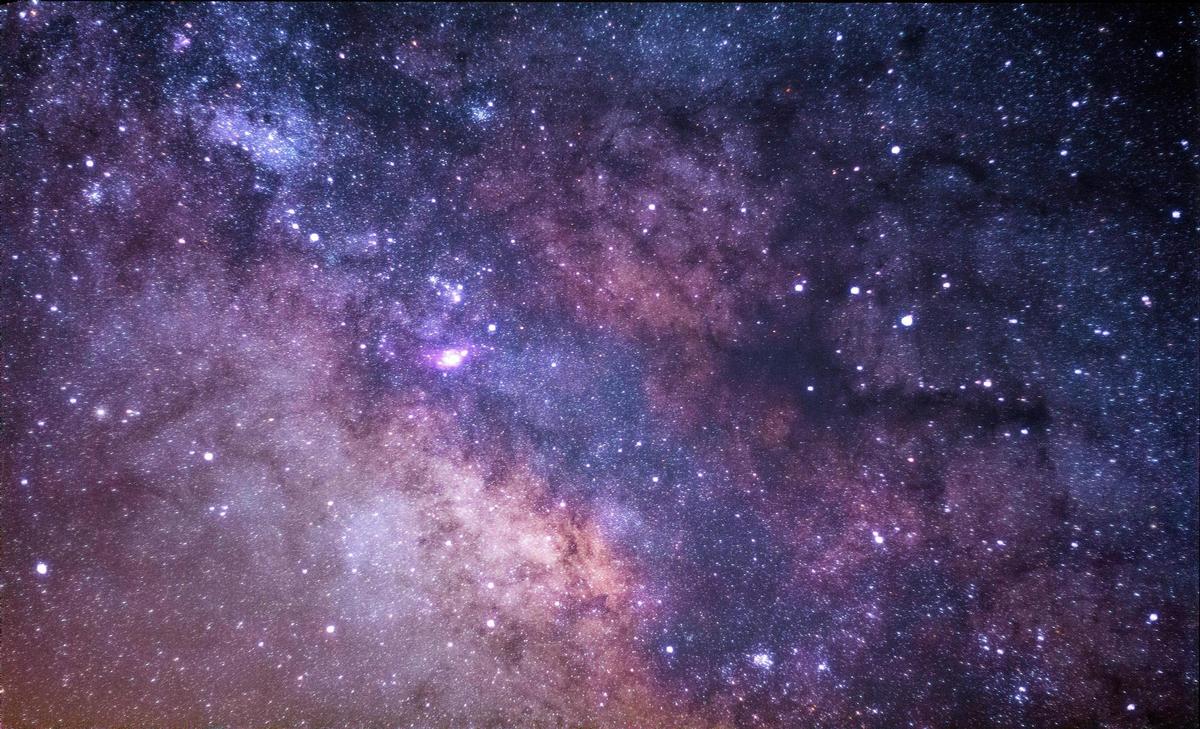

Aggiornato il giorno 3 gennaio 2021
Prossimo e difficile d’afferrare è il Dio
Ma dov’è il pericolo, cresce anche ciò che salva - Friedrich Hölderlin, Patmos
Lo ammetto: scrivere di droga, per me, è come camminare sulle uova o sui tizzoni ardenti. La droga è stata una esperienza centrale della mia vita, un despota che ha regnato diciott’anni per via diretta o indiretta, prima come totalità e poi come ombra di un passato che non voleva saperne di passare. E in fondo anche un po’ adesso regna attraverso domande a cui è difficile, forse impossibile rispondere. Fra tutte la più ineludibile e urticante è: "Perché mi sono drogato? Cosa cercavo? E perché ho continuato a cercare anche quando sapevo d’essere finito in un vicolo cieco, un corridoio del “death row”, la sezione dove i condannati aspettano l’iniezione letale?".
La risposta che si è soliti dare al primo interrogativo mi è sempre parsa insufficiente, parziale: non è vero che ci si droga solo perché si è nati e cresciuti in contesti sociali o famigliari degradati, segnati dalla povertà e dai conflitti. Non può essere il solo “disagio” a spiegare l’incontro con la droga. Tantomeno l’intemperanza tipica della gioventù, il fascino del “proibito” e l’insofferenza per limiti e autorità, in casa e fuori. Oddio, questo poteva essere in parte vero quarant’anni fa, quando ancora esisteva una morale “borghese”, un perbenismo occhiuto e censore, non certo adesso che gli adulti scimmiottano i giovani nei modi e nelle sembianze, nella goffa illusione di esserlo a loro volta...
Quella sulla droga è un questione rimossa di cui la politica non si occupa, sostiene Leopoldo Grosso
Ci dev’essere “altro” alla radice della droga, e questo misterioso altro mi è apparso con evidenza solo di recente, leggendo un libro e imbattendomi in una parola. Ci sono parole capaci di racchiudere mondi e dischiuderli non appena le leggi o ascolti. Come certe conchiglie: accosti l’orecchio e senti l’oceano.
Il libro è Moksha, raccolta di riflessioni, saggi e lettere di Aldous Huxley pubblicato da Mondadori. Huxley non l’avevo mai letto, lacuna figlia dall’ineguagliabile miscuglio di supponenza e ignoranza che è spesso la gioventù. All’epoca Huxley era noto come l’autore delle Porte della percezione, da cui Jim Morrison aveva tratto spunto per il nome della sua leggendaria band: The Doors. Roba obsoleta, ai miei occhi, da fratelli maggiori col mito di Woodstock e dei viaggi in India. La mia droga non era quella profumata d’incenso dei “figli dei fiori”, ma quella dura, urbana, raccontata da William Burroughs in Junkie.
Ebbene adesso, con colpevole ritardo, scopro che Aldous Huxley era un genio, un uomo con una cultura sterminata e quell’attrazione per l’ignoto di chi non smette, da quando ci ha messo piede, di farsi domande sul mondo e dunque sulla vita. Esploratore, filosofo ma anche veggente, capace di diagnosticare la malattia dell’Occidente quando tutti ne celebravano la potenza. Per Huxley questa malattia sta nella separazione tra il sapere e l’essere, nella rete concettuale che il sapere occidentale, nelle sue varie articolazioni e specialismi, ha steso sull’esperienza immediata, intuitiva, delle cose. Rete concettuale che se da un lato ha permesso di classificare il mondo e controllare la vita, dall’altro ha inaridito la capacità di percepirli nella loro totalità e al tempo stesso di sentirsi parte del Tutto. Insomma l’estasi che ciascuno di noi ha vissuto da bambino prima che saperi inerti e astratti – che ci hanno reso animali domestici e addomesticati – la soffocassero e cacciassero nell’oblio. Così quando mi sono imbattuto in una parola che Huxley usa con una certa frequenza ho provato lo stesso shock del novizio zen colpito alle spalle dal maestro, schiaffo che lo scuote dalla ruminazione mentale per risvegliarlo alla visione delle “cose come sono”.
A Roma l'eroina non è mai scomparsa
La parola autotrascendenza mi ha infatti rivelato quello cercavo, e con me milioni di ragazzi che in quegli anni si sono giocati la vita sedotti dal canto delle sirene. Autotrascendenza è la parola giusta perché dice che cercavamo non solo il piacere o una medicina al male di vivere – come si crede perlopiù – ma quel sentimento di appartenenza e fusione col Tutto che in un passato remoto, indefinibile, ci pareva d’aver provato e il cui richiamo si faceva tanto più impellente quanto più sentivamo soffocante il vestito dell’io: armatura più che vestito, pozzanghera che pretende di contenere l’oceano, prigione che a furia di raccontarsi come giardino finisce per credere di esserlo. Ma perché è nell’adolescenza che si avverte quel bisogno di superarsi, di trascendersi? Credo per due motivi, complementari.
Primo perché da adolescenti si sente per la prima volta la lacerante distanza dal mondo degli adulti e a volte anche dei coetanei, distanza che può diventare conflitto. Secondo, perché nell’adolescenza è ancora vivo il segno – non dico il ricordo, perché in quei momenti non eravamo ancora “noi” – dell’esperienza da cui tutta l’umanità è passata e passerà, il che spiega da un lato l’uso millenario delle droghe in quanto veicoli che quell’esperienza riproducono, dall’altro il loro uso massificato in un mondo che quell’esperienza ha cancellato e poi rimosso. Di quale esperienza sto parlando? Beh, immagino sia chiaro, a questo punto: dei nove mesi passati nel grembo materno. È lì che per la prima volta abbiamo provato quel sentimento di fusione col Tutto che Romain Rolland definì “oceanico” suscitando la perplessità di Sigmund Freud, troppo occupato a sezionare scientificamente l’Io per accettare l’ipotesi di una vita del tutto inconscia, allo stato puro, per di più capace di condizionare quella cosciente fino alla morte.

È questo che abbiamo cercato nelle droghe ed è per questo che non si può affrontare il problema della droga e dei suoi danni senza un radicale ripensamento di una società che in nome della ragione economica ha perso ogni legame col sacro. Non mi si fraintenda: sacro non vuol dire “al di là” ma aldiqua, finestra aperta sull’infinito che permette al nostro povero io ogni tanto di sporgersi e placare la sua sete, sentirsi investito da quel Tutto da cui proviene e a cui spera di tornare. In una parola: di essere felice. Si pensi solo ai “riti di passaggio”, esperienze anche traumatiche che le società avvedute hanno ideato per celebrare la gloria della nascita e ridimensionare la beatitudine di ciò che l’ha preceduta, riti ridotti e poi azzerati in nome del diritto “moderno” a autodeterminarsi. Risultato: la gioventù, che attraverso la durezza del rito scopriva la sua anima e manteneva la sua diversità (sviluppando una vita adulta in sintonia con le sue attitudini), è diventata una pappa indistinta spalmata su tutte le età. Si vuole e si può essere giovani a vita, col risultato di aver ridotto la gioventù a maschera, se non a caricatura.
Alla luce di quanto detto, l’approccio psico-sociale alla questione droga non può che apparirmi riduttivo, senza nulla togliere ai meriti di chi, in vari modi, si è preso cura delle persone. Ogni discorso che dipinge il tossicodipendente come una vittima o un emarginato mi ha provocato sempre una sorda ribellione. Per non parlare di quelli che conferiscono al “tossico” lo statuto di “soggetto politico” o quelli che, distinguendo nettamente tra “uso” e “abuso”, vagheggiano di “uso compatibile” ignorando la radice maniacale della dipendenza, il suo carattere totalizzante, figlio di quel Tutto che s’illude di raggiungere. Ci sono droghe di cui diventi schiavo, come l’eroina, ma anche droghe che ti possiedono, come la cocaina iniettata in vena.
Sia chiaro: molto meglio di quei discorsi e approcci che invocano per il tossico la mano ferma che gli sarebbe mancata, finendo per criminalizzare l’uso di droga senza più nemmeno distinguere tra lo spaccio legato all’uso e quello legato al profitto.
E tuttavia discorsi che, in entrambi i casi, ignorano il punto cruciale: la tossicomania non ha una radice sociale anche se si sviluppa giocoforza nella società. Alla radice della tossicomania c’è quella fame d’infinito con la quale veniamo al mondo, fame che, se non trova pane per i suoi denti – cioè società che si curino del nostro essere e non solo del nostro avere – trova nelle droghe il più soddisfacente dei surrogati.
Lavialibera ha dedicato il secondo numero della rivista alle droghe. Leggi Consumi stupefacenti
E siccome mai come in questo Occidente la cura dell’essere è affidata all’inventiva e capacità del singolo, la società del consumo ha avuto gioco facile nel mercificare la fame d’infinito e così occultare lo scandalo della tossicomania, figlio impertinente che denuncia la freddezza e l’indifferenza dei famigliari. Questo è il tempo della normalizzazione della droga, cioè della droga “compatibile” e tollerata. È bastato, a mafiosi e spacciatori, ampliare l’offerta e ridurre i prezzi a livelli “popolari”, confidando nell’aumento esponenziale della domanda. Cinque euro o anche meno per farsi: a noi tossici degli anni Ottanta non sarebbe parso vero… Sta di fatto che un tossico che non ha più bisogno di rubare, rapinare o scippare passa di fatto inosservato. Tanto più se raggruppato in aree ai margini della città o in spazi predisposti. Ebbi occasione, all’inizio degli anni Novanta, di visitare per un reportage il “Platzspizt” di Zurigo, parco dove il tossico che da poco avevo smesso di essere poteva assumere droghe alla luce del sole e ciondolare, lo sguardo perso, tra viali e panchine. Ne fui profondamente turbato. Una versione morbida della “soluzione finale” ideata da Himmler per sterminare gli ebrei, mi parve: nella civile Svizzera, tra l’altro una delle prime nazioni a fornire eroina di Stato, i tossici potevano esistere a condizione che non disturbassero, cadaveri ambulanti che, nascosti da alberi e contenuti da inferriate, consumavano gli ultimi scampoli di vita.
Si dirà che la mia è una visione romantica, letteraria, elitaria. Non m’interessa: l’ho pagata a duro prezzo. Sono convinto che di droga si possa credibilmente parlare solo avendola vissuta. A meno di essere dotati di una sensibilità speciale come quella di Eugenio Borgna, fiore raro della psichiatria italiana, raro anche perché ispirato da una conoscenza filosofico-letteraria inconsueta in un medico dell’anima. Borgna ha incontrato gli abissi del dolore e ne ha colto la radice metafisica, ha capito il male di chi si sente apolide dell’esistenza. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e mi piacerebbe un giorno rincontrarlo. Magari per commentare insieme un passo di un poeta a me caro che non ha mancato di citare, nei suoi splendidi libri. Scrive Antonin Artaud in una lettera dal manicomio di Rodez:“Coloro che prendono droghe hanno in loro una mancanza genitale e predestinata. Oppure, poeti del loro io in vita, hanno sentito prima degli altri quel che da sempre manca alla vita”.
Meglio essere un delinquente che un borghese - Ernst Jünger
Le droghe ci annoiano col loro paradiso
ci diano, piuttosto, un po’ di conoscenza.
Noi non siamo un secolo da paradisi - Henry Michaux
Chi ama le strofe ama anche le catastrofi,
chi è per le statue dev’essere anche per le materie - Gottfried Benn
Se una cosa va detta, prima di parlare del rapporto fra droga e letteratura, è che la droga non è veicolo di creatività. C’è stata un’epoca, tra gli anni ’60 e ’70, in cui lo si pensava. Il mito è stato infranto con l’avvento della tossicodipendenza di massa. Quando la droga esce dalla stretta cerchia dei figli della media e alta borghesia, diventa arduo pensare al ragazzo di Centocelle o del Gratosoglio che, iniettata la dose, si ritira in camera a comporre i suoi Fiori del male.
La verità – per chiunque abbia avuto occasione di appurarlo – è che i testi scritti sotto l’effetto delle droghe sono di una banalità sconcertante. È vero che il processo creativo della scrittura avviene in una specie di trance, ma nell’automatismo permane sempre un margine di autocoscienza, una breccia di vigilanza. Nella droga questa zona di tensione si risolve, si placa. È come quando un ruscello impetuoso sfocia in un lago: il furore si disperde nella vastità. La droga pacifica, risolve le contraddizioni – ed è proprio questo a renderla così appetibile. Annulla la distanza da noi stessi e dagli altri. Sotto l’effetto della droga diventiamo statici, inerti e felici di esserlo. Diventiamo noi stessi opera, creazione, senza esserlo. Tutto quello che possiamo dire o comunicare, a quel punto, non può che essere banale. L’esperienza è così totalizzante da annullare la parola, che vive di scarti e di differenze. Un mondo uguale a sé stesso è un mondo del quale non si può dire nulla.
I poeti e scrittori di questa bibliografia sono dunque grandi a prescindere dalla droga, il che non toglie la necessità di fare qualche distinzione. Per alcuni l’esperienza delle droghe è stata importante ma non ha rappresentato certo il leitmotiv della loro vita; per altri la droga è stata un padrone esigente e distruttivo. I primi hanno consapevolmente scelto la droga, scienziati e cavie al tempo stesso. La droga ha significato per loro un “di più” di conoscenza. È il caso di Ernst Jünger, di Henry Michaux, di Aldous Huxley. I secondi hanno iniziato a drogarsi molto giovani, spesso in età adolescenziale. La droga è stata per loro non una scelta ma un destino, l’approdo quasi obbligato di una sensibilità tale da impedire una qualsiasi organizzazione dell’io. Priva di limiti e difese, l’area di conflitto che è il terreno vitale dell’io si è trasformata in abisso.
È sbrigativo parlare a riguardo di “personalità autodistruttive”: la distruzione, in un uomo – tanto più se creatore, artista – non è a volte che l’effetto di un troppo forte conato a essere. Modello paradigmatico è qui Antonin Artaud. Ad Artaud andrebbero associati altri scrittori per i quali la droga è stata un’esperienza capitale – nel doppio senso dell’importanza e della fatalità – come Georg Trakl e Geza Csath.
C’è poi una terza categoria, a cui ricondurre Gottfried Benn e René Daumal. È la categoria di chi in gioventù ha provato la droga, ne ha sperimentato l’incanto e la potenza fascinatrice, ma è andato oltre, trasformando il ricordo di quell’esperienza totalizzante e totalitaria nel pungolo di una ricerca volta a trovare l’assoluto nel relativo, nella quotidianità. Per Benn questa ricerca si è svolta nell’ambito della parola, di quella “prosa assoluta” in cui poesia e narrazione diventano un’unica cosa. Daumal ha cercato la confluenza di sapere e essere nei testi della sapienza orientale e nell’alpinismo: scalando libri e leggendo montagne.
C’è infine un autore che fa categoria a sé: William Burroughs. Perché a sé? Perché Burroughs rappresenta, a differenza di tutti gli altri, la droga post-romantica. Se Artaud, Trakl, Csath sono stati tossicomani, Burroughs è stato tossicodipendente. Nel passaggio da “manìa” a dipendenza la droga si secolarizza, diventa fatto sociale. Se il vincolo della tossicomania riguardava l’anima, era riflesso della comunione col dio perseguita dagli antichi con i riti misterici, il vincolo della dipendenza riguarda unicamente il corpo-materia.
In Junkie, pubblicato in Italia nel 1951 come La scimmia sulla schiena, appare per la prima volta la droga-massa, la droga mercato, la droga polizia, la droga terapia. A fare da sfondo ai tormenti del tossico non sono più salotti borghesi, stazioni termali, cliniche immerse nella quiete dei boschi, ma il paesaggio desolato delle periferie e dei vicoli suburbani.
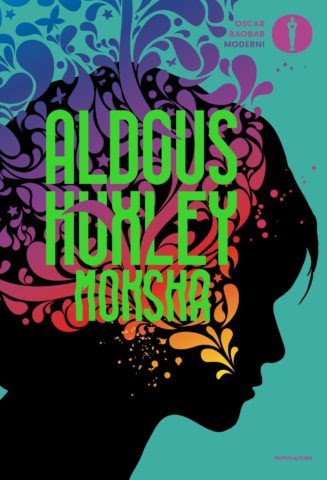
William Burroughs, La scimmia sulla schiena, Rizzoli;
Antonin Artaud, Al paese dei Tarahumara, Adelphi;
Gottfried Benn, Flutto ebbro, Guanda;
Ernst Jünger, Avvicinamenti, droghe ed ebbrezza, Guanda;
Henry Michaux, Conoscenza degli abissi, Quodlibet;
Aldous Huxley, Moksha, Mondadori;
La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti
Riformata. Così il governo vorrebbe la magistratura, ma l'obiettivo è solo limitarne il potere
La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti