
Milano-Cortina. Ecco come verranno spesi i 450 milioni di euro delle paralimpiadi

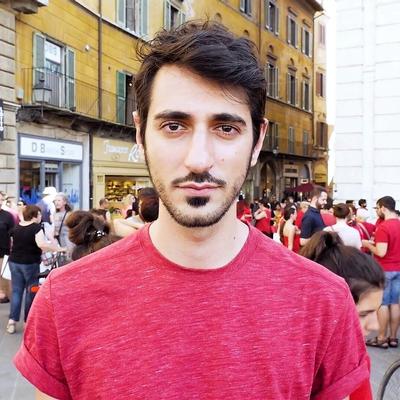
3 aprile 2025
“Ho conosciuto il dolore e visto i miei sogni diventare incubi. Nonostante ciò ho mantenuto la fede e la certezza che qualcosa di buono potesse accadere per me. Ho lottato ed ottenuto delle conquiste anche grazie alle persone e alle associazioni che mi hanno accompagnato in questo cammino. Era una promessa fatta sulle tombe dei miei cari”. Le parole, affidate a un foglio di carta ripiegato, estratto dal taschino dei pantaloni, sono di Waffo Soh Devo Leandry, giovane originario del Camerun. Durante una traversata tra l’11 e il 12 aprile 2023 il mare si è portato via suo figlio di poco meno di due anni e la moglie Sanogo, incinta del secondo. La sua testimonianza – non l’unica – fatta di rabbia e lunghi silenzi, è stata ascoltata nella sala lauree dell’Università Statale di Milano lo scorso 28 marzo nell’ambito del workshop internazionale “Migrazioni e violenze di frontiera. Pratiche del ricordo e dell’oblio attraverso il Mediterraneo” organizzato dall’Ateneo in collaborazione con una serie di realtà tra cui l’Archivio delle memorie migranti (AMM).
Respingere i migranti, uno spreco di umanità. La riflessione dell'antropologo Francesco Remotti
Waffo: "Le autorità sono rimaste ferme sul loro mezzo, mentre guardavano le persone chiedere aiuto. Sono rimasti lì, immobili per oltre un’ora prima di soccorrerci”
Prima, l’arrivo in Tunisia nel 2019. Poi, le politiche repressive della Presidenza della Repubblica tunisina giustificate, per così dire, da una retorica nei confronti dei migranti subsahariani accusati di essere al centro di un complotto atto a “cambiare la composizione demografica del Paese” come recitava un comunicato del 2023. Per Waffo e la sua famiglia non rimane che prendere il mare direzione Lampedusa. “Se noi migriamo non è per volontà nostra ma perché siamo sotto la dominazione dei nostri colonizzatori”, racconta. La piccola imbarcazione in legno partita da Sfax su cui viaggiavano si ribalterà dopo un rocambolesco inseguimento della Guardia nazionale tunisina. “Le autorità sono rimaste ferme sul loro mezzo, mentre guardavano le persone chiedere aiuto. Sono rimasti lì, immobili per oltre un’ora prima di soccorrerci”. Waffo viene incaricato insieme ad altri sopravvissuti di ripescare i corpi tra i quali riaffiorerà anche quello della moglie.
Migranti, morti senza nome. Mentre qualcuno li cerca ancora
Rientrati in porto, sempre su ordine della Guardia nazionale i cadaveri vengono disposti sulla banchina prima di essere smistati tra diversi cimiteri. Per il giovane inizia un’odissea, geografica e burocratica, per riuscire a ritrovare i corpi dei suoi cari, identificarli, dare loro la dovuta sepoltura. Passerà del tempo prima di scoprire che la moglie e il figlio si trovano in due diversi cimiteri, sepolti sotto colate di cemento senza nome. Da allora per Waffo, così come per molti altri prima e dopo di lui, è iniziata una nuova vita scandita dalle richieste del diritto all’identità e al lutto, ma anche alla memoria. Negli anni si sono moltiplicate le richieste dei famigliari di aiutarli a ritrovare i propri cari. Anche su queste istanze si fonda la mission di associazioni come Mem.Med. (Memoria Mediterranea). “Non esiste un diritto alla ricerca della salma, all’identificazione, alla sepoltura se non per motivi di igiene e sicurezza pubblica. Sono motivi di frustrazione e discriminazione per i famigliari”, spiega Serena Romano, avvocata dell’associazione. “Sono diritti deboli che ancora oggi si limitano ad assurgere a un rango di istanza culturale o religiosa”.
Il tema dell’incontro organizzato dall’Università di Milano ha toccato proprio questi aspetti. A margine delle testimonianze di famigliari e sopravvissuti, vengono poste le azioni di impegno sociale per “costruire forme di memoria pubblica e collettiva”, ma anche per tenere alta l’attenzione sul fenomeno delle morti nel mar Mediterraneo andando oltre le “necropolitiche” europee e l’oblio prodotto dalle narrazioni contemporanee. “Era importante creare un momento dove poter ascoltare queste voci”, dice Monica Massari, professoressa dell’Università di Milano e membro del comitato scientifico de lavialibera, tra le organizzatrici dell’incontro. “La cronaca quotidiana – aggiunge – ci restituisce una narrazione che tende a diventare ripetitiva e normalizzante quasi a voler narrare l’inevitabilità di queste stragi. Ciò che accade tende a generare uno stato di indifferenza nei confronti delle persone che perdono la loro vita, ma anche nei riguardi delle cause: delle politiche e delle pratiche che inducono tutto ciò”.
L'ex presidente della Tunisia Marzouki: "Fare accordi con i regimi non fermerà le partenze"
Secondo le stime riportate dal portale dell’International Organization for Migrations (Iom), Missing migrants project, 31.764 sarebbero le persone morte o disperse nel Mediterraneo dal 2014. Nel solo 2024, le vittime sarebbero 2.476 (8.962 in tutto il mondo, se si considerano anche le altre frontiere marittime e terrestri). Silvia Di Meo, ricercatrice dell'Università di Milano, parla di “naufragi invisibilizzati, più che invisibili”. Il mezzo per combattere questa invisibilità indotta sono le “pratiche di contromemoria” frutto delle alleanze nate negli anni lungo le due sponde del mare, nei movimenti di protesta necessari a “rovesciare la narrazione egemonica sulle stragi in mare che vuole ridurre a numeri i volti e i nomi; che disumanizza le vite e rende anonime le persone”.
Un esempio è racchiuso nella storia di Jalila Tamallah, madre di Hedi e Mahdi, giovani di 24 e 22 anni naufragati insieme ad altre quattro persone dopo essere partiti dalle coste di Biserta, in Tunisia, verso la fine del 2019. “Le famiglie sono esse stesse vittime. Non possiamo essere additati come responsabili di queste morti”, racconta Jalila. “Non è un crimine attraversare i confini. Se dobbiamo criminalizzare qualcuno, dobbiamo criminalizzare quelle stesse Istituzioni che impediscono le condizioni per raggiungere l’Europa legalmente”. La promessa fatta da Jalila ai figli è di continuare a supportare le madri di tanti giovani morti o dispersi in mare. “Anziché criminalizzare le famiglie – aggiunge – bisognerebbe aiutarle. Non bisogna preservare le frontiere, ma le vite umane”.
La storia di gruppi di famiglie tunisine che si battono per conoscere la sorte dei propri figli
Alidad Shiri è invece un giornalista fuggito dall’Afghanistan ad appena 9 anni, diventato dopo il naufragio dello scorso 25-26 febbraio 2023 uno dei portavoce delle famiglie della strage di Cutro. Da un video pubblicato nelle ore successive alla tragedia, la famiglia di Alidad riconosce quello che potrebbe essere suo cugino sulla Summer Love. “Sono andato al Palamilone (il palazzetto dello sport di Crotone dov’erano stati disposti i feretri, ndr) per trovare mio cugino, ma dopo una verifica fotografica scopro che non c’era”, racconta. Una volta sul posto, si rende conto dei problemi, della carenza di mezzi, delle barriere linguistiche e delle difficoltà legate al riconoscimento delle vittime da parte delle famiglie. Decide di rimanere a dare supporto come mediatore culturale. “Io credo che nessuno voglia diventare un rifugiato”, riflette Alidad paragonando quel racconto alla sua esperienza. “Ma arriva un momento in cui, pur volendo tornare al tuo Paese sai che non puoi più farlo e devi guardare avanti”.
Durante le testimonianze, sul tavolo, davanti a Waffo e a Jalila, stanno in piedi due bottiglie piene di storia e colore, che mostrano sul bordo le foto dei loro cari scomparsi. Una “richiesta di soccorso inviata al mondo” come in quel famoso pezzo dei Police Bouteilles a la mer (Bottiglie in mare) è il progetto della fotografa e artista Séverine Sajous. L’idea è quella di raccogliere terra, foto, oggetti, scritti appartenuti alle persone scomparse in mare, all’interno di bottiglie. Le opere prendono forma attraverso il racconto dei famigliari, per creare un intreccio tra materia e simboli capaci di “tradurre in sostanza memorie non statiche, ma in continuo divenire”. Il portale del progetto presenta così una mappa, idealmente tracciata da queste bottiglie restituite dal mare nella loro essenza. “Abbiamo voluto identificare – spiega la creatrice – i luoghi da cui molte persone hanno preso il largo verso il loro destino”. Vengono così evidenziate alcune aree lungo le coste libiche o tunisine “come punti di partenza e speranza, ma anche di rottura, espulsione, repressione e confinamento. Le famiglie con cui condividiamo questa esperienza hanno parlato di questi luoghi, li hanno permeati di storie e immaginazione”.
Strage di migranti nel Mediterraneo: il barcone simbolo dei naufragi è stato dimenticato
A detta di Costanza Meli, storica dell’arte tra le creatrici dell’Associazione Isole, la pratica artistica espressa attraverso queste bottiglie rappresenta un esempio di “anti-monumento, contro la retorica dei memoriali” sempre più presenti nello spazio pubblico, sempre più “funzionali ad un contesto di potere fondato esso stesso sulla diseguaglianza” che “partecipa la memoria in modo strumentale, per autoassolversi”.
Alla memoria e al valore dei silenzi sono invece affidate le conclusioni di Sandro Triulzi, dell’Archivio delle memorie migranti. Per il docente ci sono due tipi di silenzio: quello normativo, “che ovviamente va colmato” se vogliamo che il diritto continui ad essere “universalità di relazioni” e non “categoria politica”; ma c’è anche un “silenzio d’ascolto, creato dall’ascolto del dolore, che è riparatorio”. “Abbiamo bisogno di questi silenzi benefici – conclude Triulzi – di questi lutti da elaborare insieme per stare più vicino alle persone, alle popolazioni che soffrono il mondo” e ci chiedono di creare “un ambiente di rispetto e dignità anche per i loro sogni e per il nostro futuro”.
Crediamo in un giornalismo di servizio di cittadine e cittadini, in notizie che non scadono il giorno dopo. Aiutaci a offrire un'informazione di qualità, sostieni lavialibera
La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti
La tua donazione ci servirà a mantenere il sito accessibile a tutti